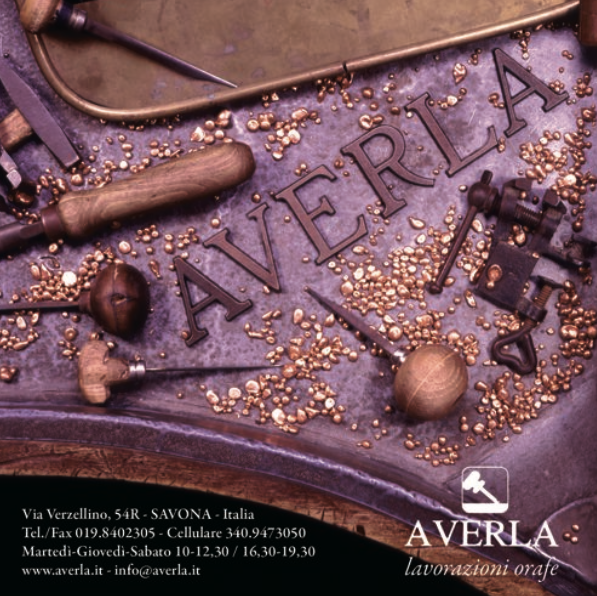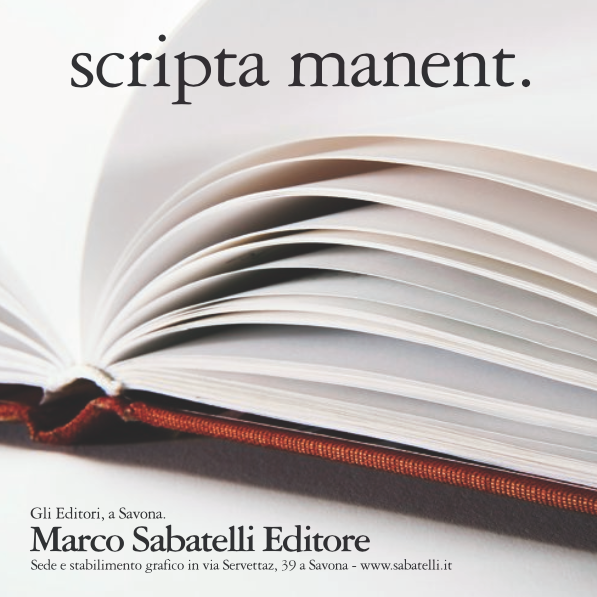Sin dall’antichità le popolazioni insediate nella valle del Pora hanno avuto un’economia prevalentemente agricola, pur dedicandosi alla pastorizia e alla selvicoltura.La presenza di numerosi piccoli insediamenti rurali (Ruccà, Carbuta, Eze, ecc. ) è la testimonianza dell’esigenza delle popolazioni del luogo di controllare e di usare in modo capillare le risorse del vasto territorio.
Sin dall’antichità le popolazioni insediate nella valle del Pora hanno avuto un’economia prevalentemente agricola, pur dedicandosi alla pastorizia e alla selvicoltura.La presenza di numerosi piccoli insediamenti rurali (Ruccà, Carbuta, Eze, ecc. ) è la testimonianza dell’esigenza delle popolazioni del luogo di controllare e di usare in modo capillare le risorse del vasto territorio.
Il paese di Calice è la risultanza della crescita di questi piccoli agglomerati ed è diventato, quale centro di fondo valle e con una strada facilmente percorribile anche per il trasporto di merci, il luogo più importante della vallata di antica vocazione agricola.Il torrente Pora ha creato attorno al paese un’area alluvionale pianeggiante dove si sono potute realizzare coltivazioni intensive e irrigue.
Recenti ritrovamenti archeologici hanno messo in luce un sito neolitico all’aperto nei dintorni di San Sebastiano di Perti, datato a circa 8000 anni fa, che risulta essere uno dei più antichi insediamenti agricoli liguri.Evidentemente la buona esposizione, la fertilità del suolo e la facile percorribilità del fondo valle erano caratteristiche che già nella preistoria l’uomo aveva riconosciuto a questo territorio.
Dopo una vasta occupazione della zona in età neolitica. che ha lasciato numerosissime testimonianze nelle grotte dei dintorni, a partire dalla fine del secondo millennio a.C. si assiste ad un graduale cambiamento del tipo di economia: a fianco dello sfruttamento delle risorse boschive e delle attività agro-pastorali, si incrementano gli scambi commerciali.
Il Castellaro di Rocca di Perti, chiamato anche Villaggio delle Anime, era un abitato d’altura nei pressi di Calice risalente alla prima età del Ferro. Esso doveva servire, oltre che come luogo di difesa anche per tenere sotto controllo la costa e le vie di accesso alle zone dell’entroterra.In tempi più recenti la storia di Calice ha risentito delle vicende che hanno coinvolto i territori confinanti: questa parte del territorio del Finale si è trovata in posizione di cuscinetto tra due popolazioni liguri di grande importanza, gli Ingauni e i Sabazi.
Si deve ricordare che tra la chiesa di San Sebastiano e Calice, precisamente in località Mordeglia, si sono ritrovati i resti di un lastricato largo 4 e lungo 12 metri appartenenti ad un ponte a più arcate in grandi blocchi squadrati già ricordato da fonti medievali (Pons Paule) probabilmente di origine romana poiché situato sul percorso originario della Via Julia Augusta, aperta nel 13-12 a.C.
Il centro abitato ha seguito le vicende storiche del Marchesato del Finale, che era stato dato in feudo ad Aleramo di Monferrato e da questi passato a Enrico il Guercio del Carretto. Nel 1449 Galeotto del Carretto dopo la fine della guerra con Genova, dona alla parrocchia di Calice una preziosissima coppa d’argento istoriato, decorata con lo stemma dei del Carretto e le effigi di San Nicolò e San Martino patroni delle chiese, quale riconoscimento di fedeltà al Marchesato.Nell’anno 1546 governò il Marchesato Alfonso II del Carretto, uomo avido e senza scrupoli. Nel 1558 partì da Calice la rivolta contro il marchese, che si estese a tutto il territorio del Finale e costrinse il del Carretto ad una lunga reclusione nel suo castello.
Principale capo della sommossa fu Antonio Capellino, umile contadino di Calice che trasgredì agli ordini del marchese Alfonso, il quale voleva essere nel suo feudo Papa, Imperatore e Re, operando anche contro le leggi da lui stesso emanate.Narra la leggenda che Antonio Capellino, il giorno delle sue nozze, invece di portare la moglie al Marchese, gli portò un’asina, marciando alla testa di un centinaio di uomini, eliminando così lo ius primae noctis e contribuendo alla libertà del Marchesato.
In realtà la Repubblica di Genova, che mirava ad un controllo su quel territorio, aiutò la rivolta inviando anche mercenari tedeschi a dar manforte ai rivoltosi.Quindi dal 1598, anno in cui Giovanni Andrea Sforza del Carretto vendette il Marchesato a Filippo II re di Spagna, al 1713 seguì la dominazione spagnola, che terminò con l’acquisto del territorio da parte della Repubblica di Genova che ne mantenne la proprietà fino al 1796.Nell’aprile del 1794 diecimila soldati piemontesi, passando da Carbuta, divenuta poi frazione di Calice, si mossero verso Loano per dare l’assalto ai soldati francesi ma da questi, che erano appena 200, vennero respinti e dovettero riparare in Piemonte.
Nell’ottobre del 1794 più di mille soldati francesi occuparono le chiese di Calice, l’oratorio e varie case facendo razzia per giorni di provviste alimentari per ritirarsi poi sulle montagne unendosi al grosso dell’esercito napoleonico.Nel luglio del 1795 l’esercito austro-piemontese arrivò a Finale, passando dai monti sopra Calice e qui, precisamente in località San Giacomo, avvenne un grave episodio che coinvolse le diplomazie dei paesi contendenti poichè i soldati dell’armata austro-sarda, nel caso specifico si trattava di panduri e croati, massacrarono a colpi di sciabola i soldati francesi feriti come azione di rappresaglia.
L’esercito francese si ritirò, salvo poi contrattaccare nel novembre dello stesso anno. La famosa battaglia di Loano avvenne nel novembre del 1795.Nell’aprile del 1796, all’inizio della prima campagna d’Italia di Napoleone, il generale Augereau e la sua colonna di soldati, furono accompagnati da un contadino di Rialto (una località sopra Calice) il quale in cambio di una lira li guidò attraverso il territorio del paese sottostante e li condusse per il passaggio di San Giacomo fino alla Valbormida, dove si unirono alle colonne dei generali Massena e Rusca e quindi finalmente a Napoleone.
Il territorio del Finale, al quale apparteneva anche Calice, fece parte della Repubblica Ligure dal 1797 al 1804. Nel 1805 passò alla Repubblica Francese che stabilì con decreto governativo l’annessione di Carbuta, ancora oggi l’unica frazione del paese, a Calice Ligure. Appartenne quindi all’Impero Napoleonico dal 1805 al 1815 e, dopo il Congresso di Vienna, al Regno di Sardegna.Nel 1863 il paese di Calice venne inserito nel circondario di Albenga con Regio Decreto di S .M .Vittorio Emanuele II e solo il 9 giugno 1930 potè assumere la denominazione di Calice Ligure.
Tra le figure più rilevanti della storia del paese dobbiamo ricordare Nicolò Sasso, che nacque a Calice il 3 marzo del 1661 ed emigrò per cercare fortuna verso la Spagna; oltrepassato lo stretto di Gibilterra si fermò a Cadiz per poi ripartire alla volta del Messico dove in data 14 marzo 1721 redasse il suo testamento con la speranza di finire la sua vita terrena nel paese natale. Morì invece a La Habana (Cuba) nello stesso anno senza fare più ritorno in patria.Il Sasso partecipò alla prima grande emigrazione che vide centinaia di abitanti del Finalese trasferirsi a Cadiz per trovare occupazione in attività stagionali collegate alla pesca e alla lavorazione del tonno.
Si pensa che avesse esercitato una redditizia attività commerciale tanto da permettergli di costituire un cospicuo patrimonio. Le sue disposizioni testamentarie assegnarono a Calice grosse somme di denaro per le chiese del paese ma soprattutto per l’istituzione di una scuola pubblica gratuita per i bambini calicesi.I terreni ed i beni di proprietà della scuola, acquisiti con il lascito testamentario di Nicolò Sasso, sono successivamente diventati per disposizioni di legge proprietà del Comune di Calice che fino ad oggi ne ha disposto l’uso a beneficio della scuola del paese.
Un altro personaggio che ha lasciato un ricordo nella memoria di Calice è il commerciante calicese Raffaele Bolla che alla fine del 1800 imbarcava fusti di vino locale per l’Argentina, destinandolo alla comunità italiana di Buenos Aires, dove realizzò l’emporio L‘almacien el Barbarossa (il magazzino del Barbarossa) dal nome del famoso vitigno Barbarossa coltivato a Calice ed ora quasi scomparso.La zona di Calice era infatti già allora rinomata per il suo ottimo vino che produceva in grande quantità.Dall’Argentina veniva invece importata la yerba (gerba o mate) con la quale si preparavano infusi simili al tè.
Arrivando quasi ai giorni nostri, durante la guerra di Liberazione agiva nella zona la tristemente nota controbanda.Si trattava di un nucleo di soldati appartenenti al Battaglione San Marco che agiva con particolare ferocia e crudeltà contro le formazioni di ribelli ed anche contro la popolazione civile al fine di contrastare l’aiuto da loro portato ai partigiani. L’eccidio di Pian dei Corsi, del quale è stata responsabile questa banda, avvenne il 2 febbraio 1945 e vi persero la vita undici giovani combattenti per la libertà.
La storia più recente di Calice vede il paese quale importante centro di attività di artisti contemporanei che hanno animato culturalmente il paese. Siamo negli anni ’60 quando Emilio Scanavino, ceramista e pittore, figlio di calicesi dopo studi a Genova ed un lungo percorso artistico, giunge alla fama internazionale, diventando uno dei maestri della pittura informale, più precisamente gestuale, proponendo opere segnate da tagli, graffi, nodi e intrecci quali costanti della sua visione della vita.
A lui si deve la promozione del Museo d’Arte contemporanea Remo Pastori, che viene costituito negli anni ’80 e che rappresenta un’importante realtà culturale in quest’area della Liguria.
Il museo possiede una collezione di opere di autori che documentano un panorama molto ampio della produzione artistica di quegli anni. In occasione dell’iniziativa Progetto per una cartolina promossa dagli stessi artisti nel 1984, il museo entrò in possesso dell’intera raccolta costituita da 81 opere eseguite da Nangeroni, Mondino, Fabbri, Pozzati, Cusumano, Scanavino e altri importanti artisti.
Guida e Calendario degli Eventi in Provincia di Savona
No Banner to display
Calendario eventi
No Banner to display

Seguici su Twitter
No Banner to display
No Banner to display
Marco Sabatelli Editore P.I.00833240096Area Riservata